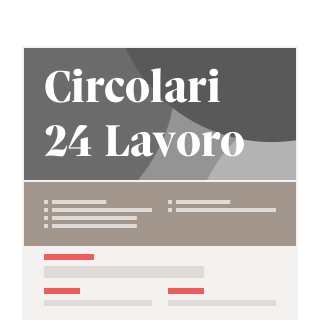Rassegna di Cassazione
Danno alla salute e oneri probatori
Nullità del patto di non concorrenza
Contratto a termine e sussistenza della causale
Rifiuto al trasferimento: legittimità e requisiti
Licenziamento per giusta causa
Danno alla salute e oneri probatori
Cass. Sez. Lav., 3 marzo 2022, n. 7058
Pres. Raimondi; Rel. Cinque; P.M. Mucci; Ric. M.A.; Contr. E. S.p.A.
Art. 2087 cod. civ. – Responsabilità oggettiva – Esclusione – Danno alla salute – Onere della prova – Esistenza del danno – Nocività dell'ambiente – Nesso causale – A carico del lavoratore – Onere di aver adottato le misure necessarie – A carico del datore di lavoro
L'art. 2087 cod. civ. non configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva, in quanto la responsabilità del datore di lavoro – di natura contrattuale – va collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento; ne consegue che incombe al lavoratore che lamenti di avere subìto, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l'onere di provare, oltre all'esistenza di tale danno, la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l'una e l'altra, e solo se il lavoratore abbia fornito tale prova sussiste per il datore di lavoro l'onere di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno.
NOTA
Un lavoratore aveva adìto il Tribunale di Sulmona ai fini dell'accertamento della responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale della società ex datrice di lavoro nella causazione di danni biologici, morali, patrimoniali e non, ed esistenziali per l'essere stato addetto all'esecuzione di mansioni usuranti – comportanti la movimentazione dei carichi, all'esposizione a vibrazioni, a posture incongrue e ad eventi climatici – senza che parte datoriale fornisse idonea tutela per i suddetti rischi, operasse una loro corretta valutazione e impartisse la formazione specifica a prevenirli.Il Tribunale, in accoglimento del ricorso del lavoratore, aveva accertato l'origine professionale della malattia occorsa al lavoratore, riconoscendogli una percentuale di danno biologico e aveva condannato la società al pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno differenziale. Sul gravame della società, la Corte di appello de L'Aquila, dopo avere espletato una nuova consulenza tecnica d'ufficio, riformava la pronuncia di primo grado rigettando la domanda iniziale del lavoratore.In particolare, la Corte territoriale evidenziava che: a) il lavoratore non aveva fornito prova sufficiente, il cui onere era su di lui ricadente, della sussistenza di specifiche omissioni datoriali nella predisposizione di quelle misure di sicurezza, suggerite dalla particolarità del lavoro, dall'esperienza e dalla tecnica, necessarie ad evitare il danno; b) in atti non vi era prova sufficiente della sussistenza del necessario rapporto di causalità tra l'attività lavorativa espletata e la malattia denunciata; c) trattandosi, infatti, di una malattia ad eziologia multifattoriale (rachipatia artrosica con protrusioni discali multiple a discreto impegno funzionale) necessitava, ai fini del riconoscimento del nesso di causalità, di una probabilità qualificata, assistita da adeguati riscontri di carattere epidemiologico, la cui dimostrazione nella fattispecie non era stata fornita.Avverso la decisione di secondo grado il lavoratore proponeva ricorso in Cassazione affidato a due motivi.La Suprema Corte, per quel che rileva, ritiene viziato l'iter logico-giuridico seguito dalla Corte d'Appello nella parte in cui – richiamati i principi in tema di ripartizione degli oneri di allegazione e prova in relazione alla prospettata responsabilità datoriale, sia extracontrattuale che contrattuale – ha ritenuto che fosse onere del lavoratore dimostrare la sussistenza di specifiche omissioni datoriali nella predisposizione delle misure di sicurezza suggerite dalla particolarità del lavoro, dall'esperienza e dalla tecnica necessaria ad evitare il danno e che solo ove tale prova fosse stata offerta sarebbe sorto per il datore di lavoro l'onere di dimostrare di avere adottato le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del pregiudizio subìto.Secondo la Suprema Corte, infatti, «il percorso argomentativo seguito dalla Corte territoriale finisce con il porre a carico del lavoratore la dimostrazione della violazione da parte del datore di lavoro di specifiche misure antinfortunistiche – anche innominate – laddove il lavoratore era tenuto solo a dimostrare il nesso di causalità tra le mansioni espletate e la nocività dell'ambiente di lavoro restando a carico del datore di lavoro la prova di avere adottato tutte le misure (anche quelle cc.dd. innominate) esigibili in concreto».Precisato quanto sopra e sulla base del principio, consolidato in giurisprudenza, di cui in massima, la Suprema Corte cassa la sentenza impugnata con rinvio al giudice di seconde cure per il riesame del materiale istruttorio e degli esiti della prova, orale e documentale, alla luce del criterio di ripartizione degli oneri probatori sopra richiamato.
Nullità del patto di non concorrenza
Cass. Sez. Lav., 8 febbraio 2022, n. 4032
Pres. Doronzo; Rel. Patti; Ric. B.M.D.P.S. S.p.A.; Controric. D.P.
Patto di non concorrenza – Corrispettivo – Pagamento in costanza – Recesso unilaterale del datore – Nullità – Configurabilità
La previsione di risoluzione del patto di non concorrenza rimessa all'arbitrio del datore di lavoro concreta una clausola nulla per contrasto con norme imperative, atteso che la limitazione allo scioglimento dell'attività lavorativa deve essere contenuto, in base a quanto previsto dall'art. 1225 cod. civ., interpretato alla luce degli artt. 4 e 35 Cost., entro limiti determinati di oggetto, tempo e luogo, e va compensata da un maggior corrispettivo: con la conseguenza che non può essere attribuito al datore di lavoro il potere unilaterale di incidere sulla durata temporale del vincolo o di caducare l'attribuzione patrimoniale pattuita.
NOTA
La Corte d'appello di Trieste rigettava il ricorso della datrice di lavoro avverso la sentenza di primo grado, che aveva accertato l'invalidità del patto di non concorrenza post-contrattuale dalla medesima stipulato con un suo dipendente con mansioni di "gestore private banker", condannando quest'ultimo alla restituzione dell'importo percepito dalla datrice di lavoro a tale titolo.La Corte d'appello riteneva, infatti, che il corrispettivo, elemento essenziale del patto, fosse ab origine non determinato, nè determinabile, essendo a discrezione della datrice il recesso in ogni momento entro la fine del rapporto di lavoro (salvo un termine di preavviso di nove mesi, sei in caso di mutamento di mansioni del lavoratore): secondo la Corte d'appello, infatti, il dipendente era ignaro del "prezzo" minimo della rinuncia al libero sfruttamento delle possibilità occupazionali e della propria crescita professionale, dopo la cessazione del rapporto di lavoro con la banca, datrice di lavoro.Avverso la sentenza della Corte d'appello ricorreva la banca datrice di lavoro davanti la Corte di Cassazione «per l'erroneo assunto di indeterminabilità del corrispettivo del patto di non concorrenza in conseguenza della facoltà di recesso unilaterale della banca dal patto medesimo in costanza di rapporto di lavoro, tenuto conto del rispetto dei requisiti prescritti per la sua erogazione in corso di rapporto (fermo un importo minimo garantito) e la previsione di un congruo preavviso (di nove mesi; sei in caso di mutamento delle mansioni del lavoratore) e soprattutto della causa dell'attribuzione patrimoniale al lavoratore, in corso di rapporto e in ogni caso acquisita, a fronte di un vincolo insorgente alla cessazione del rapporto, senza alcuna incidenza sull'equilibrio contrattuale tra le parti»La Suprema Corte rigetta il ricorso della banca decidendo come da massima sopra riportata e precisando altresì che «Nel caso di specie, l'erogazione del corrispettivo in pendenza del rapporto non elide i profili di nullità, sia di indeterminabilità temporale del vincolo sia di predeterminazione del corrispettivo, del patto tra le parti, per esserne rimessa la discrezionale e unilaterale recedibilità alla banca datrice, nella finalità di stipulazione del patto nel suo "esclusivo interesse ed in relazione alle valutazioni" dalla stessa "espresse al riguardo", a fronte della natura commutativa, sinallagmatica a titolo oneroso, del contratto».
Contratto a termine e sussistenza della causale
Cass. Sez. Lav., 18 febbraio 2022, n. 5408
Pres. Berrino; Rel. Leo; Ric. C.O.; Contr.– Ric. inc. P.I. S.p.A.
Contratto a termine – Pluralità di ragioni – Ammissibilità – Compatibilità tra le ragioni – Necessità
La pluralità di ragioni legittimanti l'apposizione del termine è pienamente legittima, non costituendo la contemporanea indicazione delle stesse incertezze sulla motivazione giustificatrice del contratto, con l'unica condizione che non sussista incompatibilità o intrinseca contraddittorietà tra le dette motivazioni.
Contratto a termine – Ragioni sostitutive – Situazione aziendale complessa – Indicazione di elementi che consentano di determinare il numero di lavoratori da sostituire – Sufficienza – Indicazione dei nominativi dei lavoratori da sostituire – Irrilevanza
In tema di assunzione a termine di lavoratori per esigenze sostitutive, nelle situazioni aziendali complesse, in cui la sostituzione non è riferita ad una singola persona, ma ad una funzione produttiva specifica, occasionalmente scoperta, l'apposizione del termine deve considerarsi legittima se l'enunciazione dell'esigenza di sostituire lavoratori assenti – da sola sufficiente ad assolvere all'onere di specificazione delle ragioni stesse – risulti integrata dall'indicazione di elementi ulteriori (quali l'ambito territoriale di riferimento, il luogo della prestazione lavorativa, le mansioni dei lavoratori da sostituire, il diritto degli stessi alla conservazione del posto di lavoro) che consentano di determinare il numero dei lavoratori da sostituire, ancorché non identificati nominativamente, ferma restando, in ogni caso, la verificabilità della sussistenza effettiva del prospettato presupposto di legittimità.
NOTA
La Corte d'Appello di Firenze, pronunziando in sede di rinvio, rilevava la nullità del termine apposto al contratto di lavoro per «esigenze tecniche, organizzative e produttive anche di carattere straordinario conseguenti a processi di riorganizzazione, ivi ricomprendendo un più funzionale riposizionamento di risorse sul territorio, anche derivanti da innovazioni tecnologiche, ovvero conseguenti all'introduzione e/o sperimentazione di nuove tecnologie, prodotti e servizi nonché all'attuazione delle previsioni di cui agli accordi del 17, 18 e 23 ottobre, 11 dicembre 2001, 11 gennaio 2002, 13 febbraio e 17 aprile 2002, congiuntamente alla necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie contrattualmente dovute a tutto il personale nel periodo estivo».Avverso tale sentenza la società datrice ha proposto (nuovamente) ricorso in cassazione censurando, in particolare, la decisione laddove la corte territoriale non avrebbe riconosciuto alcun valore agli accordi collettivi indicati nella causale del termine a garanzia della sua specificità, ed inoltre perché non avrebbe svolto alcun esame in ordine alle ragioni sostitutive indicate nella seconda parte della causale stessa.La Corte di Cassazione accoglie il ricorso della società datrice e cassa la sentenza impugnata.Innanzitutto, la Suprema Corte premette e ribadisce il proprio orientamento secondo cui l'esistenza di una pluralità di motivazioni circa l'apposizione del termine deve ritenersi legittima, a condizione che non via sia incompatibilità o contraddittorietà tra le stesse (Cass. n. 7945/2015; Cass. n. 16396/2008). In tema di assunzione a termine di lavoratori per esigenze sostitutive, la Corte di Cassazione ricorda poi che «l'onere di specificazione delle ragioni è correlato alla finalità di assicurare la trasparenza e la veridicità della causa di apposizione del termine e l'immodificabilità̀ della stessa», e che per la legittimità dell'apposizione del termine «è sufficiente l'indicazione di elementi ulteriori che consentano di determinare il numero dei lavoratori da sostituire, ancorché non identificati nominativamente» (Cass. nn. 1928/2014; 13239/2012; 8966/2012; 27052/2011; 4267/2011), come più ampiamente esposto nella massima indicata per quanto concerne, in particolare, le situazioni aziendali complesse.Fatte tali premesse, la Suprema Corte rileva, quindi, che la Corte d'Appello avrebbe dovuto esaminare il contenuto degli accordi ai quali la clausola appositiva del termine si riferiva, al fine di verificare la specificità della clausola stessa, alla luce dei principî sopra esposti. Tale esame, tuttavia, non è stato svolto dalla corte di merito che – rileva la Corte di Cassazione – si è infatti esclusivamente limitata ad osservare che nel contratto individuale si operava un generico riferimento agli accordi collettivi.
Rifiuto al trasferimento: legittimità e requisiti
Cass. Sez. Lav., 10 febbraio 2022, n. 4404
Pres. Raimondi; Rel. Amendola; Ric D.A.; Controric. X S.p.A.
Licenziamento per giusta causa – Trasferimento – Rifiuto di svolgere la prestazione nella nuova sede – Eccezione di inadempimento – Requisiti – Buona fede e correttezza – Necessità
Anche qualora si ritenga che il trasferimento sia stato disposto in violazione all'art. 2103 c.c., l'inadempimento datoriale non legittima in via automatica il rifiuto del lavoratore di eseguire la prestazione trovando applicazione il disposto dell'art. 1460 cod. civ. secondo cui la parte adempiente potrà rifiutarsi di eseguire la prestazione a proprio carico solo ove tale rifiuto risulti non contrario a buona fede e correttezza.
NOTA
La fattispecie sottoposta al vaglio della Suprema Corte attiene al licenziamento per giusta causa irrogato ad un dipendente che aveva rifiutato il trasferimento da Potenza a Pozzuoli.L'ordinanza in commento giunge a seguito dell'esperimento di tre giudizi di merito. In particolare, la Corte d'Appello di Potenza – diversamente dal giudice di prime cure – aveva ritenuto illegittimo il trasferimento e il conseguente licenziamento del lavoratore, poiché, a parere della Corte territoriale, il datore di lavoro non si era comportato secondo buona fede e correttezza nella gestione delle conseguenze che erano derivate dalla soppressione della unità organizzativa di appartenenza e, pertanto, era legittimo il rifiuto del lavoratore di recarsi presso la nuova sede. La Corte di Cassazione a seguito dell'impugnazione della sentenza da parte di entrambe le parti, cassava la sentenza, ritenendo che la Corte d'Appello non si fosse uniformata al principio consolidato secondo cui il controllo giurisdizionale delle comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive che legittimano il trasferimento del lavoratore subordinato deve essere diretto ad accertare che vi sia corrispondenza tra il provvedimento adottato dal datore di lavoro e le finalità tipiche dell'impresa e non può essere dilatato fino a comprendere il merito della scelta operata dall'imprenditore. Inoltre, aggiungeva la Suprema Corte, il trasferimento del lavoratore presso altra sede, giustificato da oggettive esigenze organizzative aziendali, consente al medesimo di chiederne giudizialmente l'accertamento di legittimità, ma non lo autorizza a rifiutarsi aprioristicamente di eseguire la prestazione lavorativa.Alla luce di tali principi, la Corte d'Appello di Potenza, in sede di giudizio riassunto, rivedeva la propria decisione affermando la effettività della misura organizzativa alla base del trasferimento del lavoratore e che il rifiuto di svolgere la prestazione da parte del lavoratore fosse contrario a buona fede poiché utilizzato «come arma per vincere le resistenze datoriali nell'ambito di una trattativa economica».Avverso tale sentenza proponeva ricorso per Cassazione il lavoratore osservando l'erroneità della decisione sia in relazione all'effettività delle ragioni alla base del trasferimento e la legittimità dello stesso, sia con riferimento alla legittimità del rifiuto.La Corte di Cassazione, innanzitutto, evidenzia come la sentenza impugnata si basi su due autonome rationes decidendi: (i) la legittimità del trasferimento e, in ogni caso, (ii) la contrarietà a buona fede e correttezza dell'eccezione di inadempimento e conseguente rifiuto del lavoratore di svolgere la prestazione.Prosegue, poi, affrontando il motivo di ricorso inerente all'eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 cod. civ.Sul punto la Corte ribadisce il principio secondo cui in caso di trasferimento adottato in violazione dell'art. 2103 c.c., vertendosi in ipotesi di contratto a prestazioni corrispettive, trova applicazione il disposto dell'art. 1460, comma 2 c.c. alla stregua del quale la parte adempiente può rifiutarsi di eseguire la prestazione a proprio carico solo ove tale rifiuto, avuto riguardo alle circostanze concrete, non risulti contrario alla buona fede. La verifica in merito alla sussistenza di tale requisito, riservata ai giudici di merito, deve essere condotta «sulla base delle concrete circostanze che connotano la fattispecie, nell'ambito delle quali si potrà tenere conto, in via esemplificativa e non esaustiva, della entità dell'inadempimento datoriale in relazione al complessivo assetto di interessi regolato dal contratto, della concreta incidenza del detto inadempimento datoriale su fondamentali esigenze di vita e familiari del lavoratore, della puntuale, formale esplicitazione delle ragioni tecniche, organizzative e produttive alla base del provvedimento di trasferimento, della incidenza del comportamento del lavoratore sulla organizzazione datoriale e più in generale sulla realizzazione degli interessi aziendali, elementi questi che dovranno essere considerati nell'ottica del bilanciamento degli opposti interessi in gioco». Coerentemente la Corte d'Appello di Potenza ha deciso sulla base di tali principi e tale valutazione non è sindacabile in sede di legittimità.Dunque, la Corte essendo sussistente una delle rationes decidendi alla base dell'impugnata sentenza, ha ritenuto ultronea la verifica della fondatezza delle ulteriori censure, non potendosi giungere, in ogni caso, alla cassazione della sentenza e ha rigettato il ricorso.
Licenziamento per giusta causa
Cass. Sez. Lav., 2 marzo 2022, n. 6796
Pres. Raimondi; Rel. Cinque; P.M. Mucci; Ric. A.G.; Controric. I.C. S.p.A.
Licenziamento individuale – Giusta causa – Pluralità di fatti – Parziale sussistenza delle condotte contestate – Insussistenza del fatto – Non sussiste – Fatti sussistenti ma non illeciti – Insussistenza del fatto – Sussiste – Sproporzione tra condotta e sanzione – Tutela risarcitoria ex art. 18, comma 5, L. 300/1970
Nel caso di licenziamento disciplinare intimato per una pluralità di distinti ed autonomi comportamenti, solo alcuni dei quali risultino dimostrati, la "insussistenza del fatto" si configura qualora possa escludersi la realizzazione di un nucleo minimo di condotte astrattamente idonee a giustificare la sanzione espulsiva, oppure se si realizzi l'ipotesi di fatti sussistenti ma privi del carattere di illiceità, ferma restando la necessità di operare una valutazione di proporzionalità tra la sanzione e i comportamenti dimostrati. Nell'ipotesi di sproporzione tra sanzione e infrazione va riconosciuta la tutela risarcitoria se la condotta dimostrata non coincida con alcuna delle fattispecie per cui i contratti collettivi o i codici disciplinari applicabili prevedono una sanzione conservativa, ricadendo la proporzionalità tra le "altre ipotesi" di cui all'art. 18, comma 5, L. 300/1970, per le quali è prevista la tutela indennitaria forte.
NOTA
La Corte d'Appello di Perugia, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Spoleto, dichiarava risolto il rapporto di lavoro del dipendente a far data dal licenziamento per giusta causa e condannava il datore di lavoro al pagamento di un'indennità risarcitoria omnicomprensiva pari a 18 mensilità, ai sensi dell'art. 18, comma 5, L. 300/1970. In particolare, la Corte rilevava che alcuni dei fatti oggetto di contestazione si fossero rivelati diversi da quanto realmente accaduto, mentre altri comportamenti del lavoratore – che aveva parzialmente fruito di permessi per l'assistenza ad un familiare disabile per svolgere attività estranee all'assistenza medesima – fossero sussistenti ma non tali da giustificare il licenziamento per giusta causa, che quindi risultava non proporzionato rispetto ai fatti.Il lavoratore proponeva ricorso per Cassazione eccependo, inter alia, la violazione dell'art. 33, comma 3, e dell'art. 3, comma 7-bis, L. 104/1992, deducendo che il proprio comportamento non integrasse né una giusta causa né un giustificato motivo di licenziamento. Inoltre, il ricorrente eccepiva la violazione dell'art. 2119 cod. civ. e dell'art. 18, L. 300/1970, per avere la Corte d'appello ritenuto applicabile soltanto il rimedio indennitario in luogo della tutela reintegratoria, sebbene avesse affermato l'insussistenza della giusta causa di licenziamento e l'assenza di proporzionalità tra i fatti e la sanzione medesima.La Corte di Cassazione ritiene i motivi infondati.Innanzitutto, precisa la Corte, il giudice di merito ha ritenuto la sanzione sproporzionata rispetto ai fatti sulla base di una corretta valutazione complessiva delle circostanze. In particolare, ha ritenuto provata la condotta del lavoratore, che durante la fruizione di permessi ex L. 104/1992 aveva svolto attività estranee alle finalità di cura proprie dell'istituto. Al contempo, il giudice ha ritenuto che tale abuso del diritto si fosse verificato per un lasso di tempo limitato (il 18,75%) e, pertanto, non fosse di una gravità tale da determinare il venir meno dell'elemento fiduciario alla base del rapporto di lavoro.In definitiva, quindi, alcuni dei fatti contestati erano stati ritenuti sussistenti nella loro materialità, nonché rilevanti sul piano disciplinare in quanto integranti una violazione delle norme contrattuali; tuttavia, l'inadempimento del lavoratore non era idoneo a configurare una giusta causa o un giustificato motivo di licenziamento, con conseguente applicazione della tutela risarcitoria di cui all'art. 18, comma 5, L. 300/1970.La Suprema Corte ribadisce al proposito il proprio orientamento consolidato, secondo cui l'accertamento dei fatti e il successivo giudizio circa la gravità degli stessi e la proporzione della sanzione è riservato al giudice di merito, che – anche qualora riscontri l'astratta corrispondenza tra infrazione e fattispecie prevista contrattualmente – deve valutare la legittimità e la congruità della sanzione, tenendo conto di ogni aspetto concreto della vicenda (Cass. 26010/2018). La decisione della Corte d'appello è conforme a tale principio, nonché a quello secondo cui in caso di licenziamento disciplinare intimato per più comportamenti distinti e autonomi – solo alcuni dei quali risultino dimostrati – l'"insussistenza del fatto" si ha soltanto qualora possa escludersi perfino l'esistenza di un nucleo minimo di condotte astrattamente idonee a giustificare il licenziamento, oppure se si realizzi l'ipotesi di fatti sussistenti ma privi del carattere di illiceità. Resta ferma la necessità di operare in ogni caso una valutazione di proporzionalità tra sanzione e fatti, con la conseguenza che in caso di sproporzione, andrà riconosciuta la tutela risarcitoria qualora i fatti contestati non coincidano con alcuna fattispecie per cui la contrattazione collettiva prevede una sanzione conservativa. Il vizio di proporzionalità, infatti, rientra in una delle ipotesi di cui all'art. 18, comma 5, L. 300/1970, per cui è prevista la tutela indennitaria "forte", cioè tra 12 e 24 mensilità della retribuzione di fatto del dipendente (Cass. 31529/2019).Per le ragioni che precedono, il ricorso viene rigettato.







-U28635755538JHW-735x735@IlSole24Ore-Web.jpeg?r=86x86)